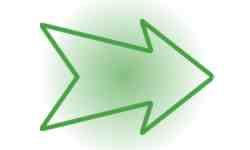|
|
    
|
|
Galileo Galilei
La nascita del pensiero scientifico moderno di Davide Bucci Introduzione Galileo Galilei è un personaggio al
quale la cultura scientifica moderna deve certamente moltissimo; forse è
stato uno dei primi scienziati –i quali all’epoca si definivano “filosofi
della natura”– ad aver inteso veramente la scienza non più in termini
qualitativi, ma in una visione quantitativa dalla quale la matematica non
poteva essere esclusa. Ecco cosa viene detto in proposito da A. Einstein e
L. Infeld su di un loro classico libro di storia della fisica: “La
scienza collegante teoria ed esperimento non data realmente che dagli
scritti di Galileo”. Prima di lui, l’astronomia e gli eventi
naturali venivano spiegati in termini aristotelici, ossia secondo un
corpus di dottrine che Aristotele aveva presentato in alcuni libri fra i
quali il De caelo. La fisica aristotelica concepiva una descrizione del
mondo in termini antropocentrici ed abbastanza legati alle esperienze
comuni che si presentano ai nostri sensi, in particolare, la fisica era in
gran parte legata allo studio del moto dei corpi solidi che venivano
classificati in “leggeri” o “gravi” a seconda della loro naturale tendenza
verso l’alto (il vapore, il fumo) oppure verso il basso1.
Situazione storica all’epoca di Galileo La vita di Galileo si svolse in un epoca in cui
l’Italia stava uscendo dal Rinascimento, un periodo di notevole fermento
intellettuale; lo stesso anno della nascita dello scienziato (1564) vide
la morte di Michelangelo Buonarroti e, in Inghilterra, la nascita di
Shakespeare. L’Italia, dalla pace di Cateau Cambrésis (1559) fino alla
pace di Vestfalia (1648) attraversò un periodo di soggezione sia diretta
che indiretta al grande peso politico della Spagna, la quale iniziò a
formarsi un vastissimo impero coloniale oltreoceano. Nell’Italia di quel periodo figurarono in particolare la Repubblica di Venezia, lo Stato sabaudo che acquistò crescente importanza (la capitale venne trasferita da Chambéry a Torino) con Emanuele Filiberto duca di Savoia (1553-1589), la Toscana dei Medici e lo Stato pontificio, mentre tutto il meridione era sotto una pesante influenza spagnola. Un fatto di molta importanza fu poi l’affissione delle 95 tesi protestanti sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg nel 1517 da parte di Martin Lutero e che avrebbero poi scatenato un’ampia eco culturale per tutta l’Europa e mettendo in dura crisi l’autorità pontificia; per fronteggiare questa crisi vi fu il Concilio di Trento (13 dicembre 1545-4 dicembre 1563) al cui termine la Chiesa venne proclamata diretta ed indispensabile intermediaria fra Dio e gli uomini, soprattutto per quello che concerneva l’interpretazione delle Scritture le quali però, diversamente dai protestanti, non erano considerate le uniche fonti della fede, ma erano integrate dalla tradizione derivante da Cristo e conservate dalla Chiesa. L’Inghilterra attraversava l’età elisabettiana e nel XVI secolo acquistò sempre maggior potere nel quadro delle nazioni europee, anche con la sconfitta inferta alla spedizione navale spagnola della “Invencible Armada” nel 1588. La Francia, con Enrico IV (1589-1610) venne emanato l’Editto di Nantes (1598) che conferiva libertà di culto agli ugonotti e permetteva loro di mantenere un certo numero di fortezze armate. Gli anni della giovinezzaGalileo Galilei nacque a Pisa, nel 1564 da una famiglia di mercanti abbastanza agiata, suo padre Vincenzo (1525ca-1591) fu un famoso liutista e occupò un ruolo di un certo rilievo nella vita musicale del periodo; oggi è ricordato per la pubblicazione di numerose opere teoriche, soprattutto il “Fronimo” (1568) ed il “Dialogo della musica antica et della moderna” (1581). Il giovane Galileo intraprese nel 1581 a Pisa gli studi di medicina che tuttavia interruppe senza laurearsi, ma venendo comunque a contatto con studiosi di grande levatura come Francesco Buonamici, un buon commentatore di Aristotele, ed acquisendo privatamente un considerevole bagaglio culturale nel campo della geometria.
Come vedremo, il giovane Galileo non era di questo avviso… Un fatto in particolare fu determinante per il nostro scienziato contro l’incorruttibilità dei cieli propugnata da Aristotele, e questo fu l’apparizione di una supernova nel 1604. Una supernova è forse l’ultima grande manifestazione di una stella morente, oggi si pensa che, alla fine del combustibile nucleare, stelle aventi una massa compresa fra certi limiti tendano a collassare su se stesse, per poi esplodere violentemente rilasciando quantità di energia enormi in periodi straordinariamente brevi.
Oppure posso vederle con l’occhio più esteso di Palomar, mentre fuggono veloci da qualche punto comune in cui esse si trovavano forse tutte insieme…Qual è questo meccanismo, il significato, il perchè? Non arrechiamo danno al mistero conoscendone qualche dettaglio.”2. Ciò che colpisce di Galileo è la straordinaria modernità di quello che asserisce; secondo chi scrive egli merita forse di essere ricordato forse non tanto per aver scoperto questa o quella legge fisica (cosa che peraltro non mancò di fare…), ma quanto più nell’aver ideato il contesto culturale nel quale le stesse leggi andavano inserite. La scoperta delle “stelle medicee”Un eccezionale strumento di indagine nelle mani di Galileo diventò il telescopio a partire dall’estate del 1609, periodo in cui egli venne a conoscenza dell’esistenza dello strumento ed impiegò poco tempo a comprenderne il funzionamento ed a costruirne un proprio esemplare.
In realtà, probabilmente lo studioso prese un po’ sottogamba le polemiche in cui era coinvolto, forse troppo fiducioso della protezione del Granduca fiorentino il quale però rimaneva comunque ben attento alla situazione politica… Altre osservazioni compiute da Galileo furono quelle delle fasi di Venere e delle macchie solari; pure queste ultime costituivano un grosso indizio contro la solita tesi aristotelica dell’immutabilità degli oggetti celesti.
L’opera di Ludovico e dei suoi seguaci contro Galileo viene chiamata congiura dei “colombi” e loro dimostrarono di sapersi muovere con considerevole perizia nella situazione politica e diplomatica del periodo, aspetto che Galileo, probabilmente troppo fiducioso nella protezione del Granduca, forse trascurò alquanto. Un segnale di pericolo gli giunse però quando l’ipotesi dell’inconciliabilità delle tesi da lui proposte contro la filosofia naturale aristotelica e le Sacre Scritture venne riportata alle orecchie di Cristina di Lorena, granduchessa di Toscana nonchè devotissima cristiana. Tale illazione non deve stupire: pensiamo a quanta fatica gli studiosi ed interpreti medioevali hanno dovuto fare per conciliare le ipotesi di Aristotele con la descrizione biblica ed ora saltava fuori uno che aveva la pretesa di stravolgere tutto come un immenso castello di carte! La mossa era quindi astuta e poneva in pericolo il nostro studioso il quale, per cercare di difendersi in modo adatto alla politica ed alla diplomazia del periodo, inviò una lettera all’amico Benedetto Castelli in cui egli descriveva in dettaglio ciò che pensava sul rapporto fra scienza e fede; infatti il Castelli risiedeva presso la corte di Cristina e poteva far giungere, sia pure per via indiretta, la lettera di Galileo alla duchessa. Il punto era l’intoccabilità delle Scritture per la materia di fede, ma la possibilità di interpretare i passi dedicati alla filosofia naturale in quanto, seppure ispirati da Dio, essi erano stati scritti in forma allegorica per lettori poco acculturati. Non bisognava pertanto prendere alla lettera le affermazioni relative alle questioni scientifiche, ma era opportuno interpretare con saggezza quei passi (che peraltro erano veramente pochi) i quali trattavano esplicitamente dell’organizzazione del creato. Nessun problema sorgeva fra teologia ed astronomia, ma si aveva un nettissimo contrasto fra metafisica e scienza. La situazione iniziò comunque a precipitare quando nel 1613 un domenicano, tal Tommaso Caccini, pronunciò una violentissima invettiva dal pulpito di S. Maria Novella a Firenze contro la matematica (arte diabolica) ed i matematici (eretici) e tale predica, che ovviamente non fu opera dell’iniziativa privata del frate, si fece sentire fino in Vaticano… Non dobbiamo pensare comunque che Galileo, il quale era ovviamente al centro della polemica, non avesse amici; un frate, tal Padre Maraffi gli denunciò il proprio sdegno per la posizione di Caccini e per il fatto che avesse trovato orecchie disposte ad ascoltare proprio a Roma; inoltre Federico Cesi lo invitava a prestare estrema attenzione a non esporsi troppo in quanto Roberto Bellarmino, il cardinale che nel 1600 aveva avuto un peso considerevole nella condanna al rogo di Giordano Bruno, aveva dichiarato di non accettare le tesi copernicane che risultavano così pericolosamente eretiche. Intanto il Caccini andò in Vaticano ed espose le proprie idee di fronte all’Inquisizione. Nel 1615 una copia della lettera scritta dallo scienziato a Benedetto Castelli venne fatta giungere dall’Inquisizione a Roma, accompagnata da accuse scritte dal professore fiorentino Niccolò Larini e falsificata in diversi punti; comunque, data la gravità della situazione, il Sant’Ufficio diede l’ordine di rintracciare l’originale. La questione venne chiusa da una lettera del cardinale Bellarmino al carmelitano Paolo Antonio Foscarini il quale aveva preso le parti di Galileo sostenendo la conciliabilità delle tesi eliocentriche con le Sacre Scritture, in cui era esposta con durezza la posizione ufficiale della chiesa: l’astronomo poteva dire quello che voleva nel momento in cui si trattava di fare calcoletti matematici, ma non poteva assolutamente pretendere di pervenire alla Verità la quale era, come al solito, raggiungibile solo con la metafisica aristotelica. Le dottrine eliocentriche erano così dichiarate pericolose e si mise in atto una pesante censura sulle opere di Copernico. Il commento di Galileo su questa pesante sconfitta fu tanto breve quanto significativo: “mi vien serrata la bocca”, ma il Bellarmino gli affidò una lettera che lo salvaguardava comunque da accuse e da maldicenze: “il suddetto Sig. Galileo non ha abiurato in mano nostra né di altri qua in Roma, né meno in altro luogo che noi sappiamo, alcuna sua opinione o dottrina, né manco ha ricevuto penitenzie salutari né d’altra sorte, ma solo gl’è stata denuntiata la dichiarazione fatta da N. Sig. […] nella quale si contiene che la dottrina attribuita al Copernico sia contraria alle Sacre Scritture, et però non si possa difendere né tenere” . Il nostro studioso fu dunque costretto al silenzio e, per sbarcare il lunario, cercò di utilizzare il telescopio per altri fini diversi da quelli accademici; è in questo periodo che tentò di sfruttare le prospettive economiche offertagli dalla costruzione di cannocchiali ed altri strumenti |
.